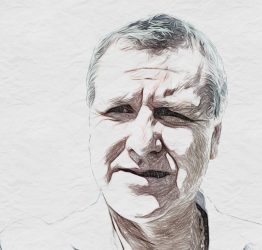In questi giorni si celebra il settantesimo anniversario della Carta Costituzionale. Naturalmente essa segna il passaggio da un regime totalitario a uno democratico e rappresenta quindi un momento fondamentale della storia del nostro Paese.
Alcuni la considerano come un simulacro intoccabile e si indignano alla sola idea che possa essere aggiornata, altri, come me, tentano una lettura più distaccata.
La Costituzione Italiana, come è noto, nacque grazie all’unità di intenti delle componenti politiche democristiana, comunista, socialista e liberale. Per quanto attiene la prima parte, alcuni articoli sono esito di alte sintesi politiche, altri sono frutto di compromessi, altri ancora di concessioni.
Lo stesso articolo che apre la Carta, secondo il quale l’Italia sarebbe una Repubblica fondata sul lavoro, racconta delle concessioni alla cultura operaista del PCI.
Per quanto riguarda invece la seconda parte, per testimoniare la discontinuità col dirigismo fascista, si è fatto ricorso a un ultrademocraticismo di facciata, retorico e inefficiente: il bicameralismo cosiddetto perfetto e lo spropositato numero di parlamentari ne sono evidenza inequivocabile.
Meglio, molto meglio avrebbero fatto i cosiddetti Padri Costituenti a domandarsi cosa generò l’insorgere del fascismo, non come differenziarsi da esso.
Si sarebbero resi conto che la dittatura trovò spazio proprio nella debolezza della democrazia pre-fascista. Ciò avrebbe suggerito di costruire una democrazia forte, non un’ultrademocrazia inefficiente e imbelle come invece si è deciso di fare.
Così ci si è trovati a fare i conti con un sistema ultrademocratico, pieno di garanzie, pesi e contrappesi, ineccepibile in astratto, ma inapplicabile nella realtà, tanto da aver costretto gli esecutivi (tutti) a governare tramite un continuo uso improprio dei decreti-legge e dell’applicazione della cosiddetta “questione di fiducia” oppure grazie a maggioranze anomali quale fu, ad esempio, quella che sostenne il Governo Monti e, in fondo, anche il Governo Letta.
L’ultrademocraticismo costringe dunque, per governare, a vere e proprie temporanee riduzioni della democrazia. Insomma, l’ultrademocraticismo genera un sistema meno democratico di quanto non sarebbe un sistema orientato alla costruzione di governi forti e stabili.
Oggi, la nuova epoca e la conseguente necessità di dare rapidissime risposte al cambiamento continuo del nostro tempo, impone un’accelerazione all’adeguamento della Carta. Lo stesso primo articolo non risponde adeguatamente alle domande che questa nuova epoca ci pone in materia di globalizzazione e competitività. Davvero pensiamo che per competere con paesi come la Cina e l’India, possa fare la differenza l’essere “fondati sul lavoro”? Che possa fare la differenza il piano delle sicurezze e delle garanzie? Per competere con paesi che, loro sì, sono davvero fondati sul lavoro, occorre mettere in campo creatività, iniziativa e innovazione.
Occorre interrogarsi: non è forse più attuale e coerente definirsi una repubblica fondata sulla centralità della persona umana, sul diritto degli individui a seguire le proprie aspirazioni e sul loro concorso allo sviluppo del Paese attraverso la loro creatività e iniziativa?
Basta coi tabù inavvicinabili, coi totem venerabili, coi simulacri intoccabili. Forse la sconfitta renziana del 4 dicembre 2016, paradossalmente, si rivelerà fattore di cambiamento. Fa bene Carlo Calenda ad alzare il tiro, a ipotizzare un’assemblea costituente: efficientare la seconda parte della Carta non è sufficiente, occorre ripensare anche i cardini valoriali del nostro vivere civile, sociale, economico.
Una Carta nata con la necessità di dare risposte “anti”, non può ragionevolmente rispondere alle sfide della nuova epoca che richiede invece risposte “per”. Allo stesso modo, non ci aiuta più disegnare istituzioni “diverse e contrapposte” a quelle pre-costituzionali, ci aiuterebbe invece disegnare istituzioni forti, semplici e chiare, superando la vuota retorica dei rischi dell’uomo solo al comando e della deriva autoritaria.
L’affermazione di una forza politica europeista, liberal-democratica, orientata a indicare soluzioni e non nemici, potrebbe rappresentare il viatico di un nuovo percorso culturale, civile e politico. Da questo punto di vista, le prossime elezioni politiche potrebbero rappresentare un’opportunità. Vedremo se qualcuno avrà la forza e il coraggio di coglierla.